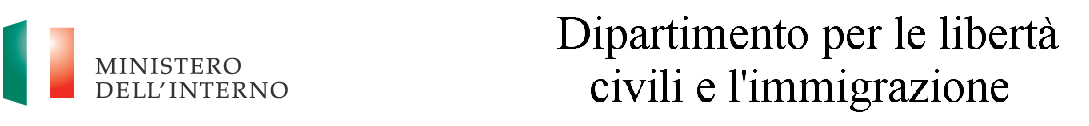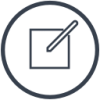Le associazioni vegetali
La descrizione del profilo vegetazionale della flora del tarvisiano è compito estremamente arduo e delicato per la complessità delle componenti e per le variazioni che si riscontrano. Il tarvisiano, da un punto di vista climatico, zona di transizione fra i climi di tipo oceanico e continentale, è caratterizzato da elevate precipitazioni, che, nel periodo invernale, ricoprono il territorio sotto una spessa coltre nevosa, variabile secondo i dati statistici dai 5 ai 10 metri. Le caratteristiche climatiche e pedologiche determinano variazioni nella compagine floristica, che assume aspetti di tipo illirico o centro europeo, secondo la prevalenza di un continentalismo o di un più marcato influsso oceanico. Dal fondovalle sino alle aree cacuminali, il profilo vegetazionale cambia al variare dei fattori ecologici, ma nella zona le eccezioni sono talmente diffuse da costituire a volte una costante. L'esempio tipico è quello del Faggio, che spesso vegeta a quote superiori della Picea, mentre il Pino Mugo scende sino al fondovalle in Val Saisera, al lago di Cave ed in altre località. Le principali associazioni vegetali riscontrabili nel territorio sono comuni a tutti gli ambienti alpini.Alle cenose forestali, riconducibili, pur con le note varianti, ai tipi principali dei boschi di Faggio, Abete Rosso e Bianco, alle pinete, ai lariceti e, in misura ridotta, agli ontaneti, si accompagna l'innumerevole schiera delle associazioni dei prati, dei luoghi umidi, delle rupi, dei pascoli a quote elevate. Nel fondovalle sono diffusi i prati, nei quali si praticano le concimazioni con stallatico e che vengono falciati anche due volte all'anno. Questi da un punto di vista floristico sono riconducibili agli Arrenatereti, a predominanza di Arrenatherium, Elatius, l'Avena Altissima, graminacea, pregiata foraggera.
Accanto a questa vegetano numerose ombrellifere, le composite come la Margherita Maggiore, la Knautia Arvensis, il Tarassaco, i Trifogli maggiormente visibili dopo il primo sfalcio, i Ranuncoli, i Melanconici Colchici, che compaiono all'imminente lungo inverno. A quote più elevate, negli spazi strappati al bosco di Faggio ed agli Abeti, nella Val Bartolo, in Val Uque, fiorisce il triseteto, nome desunto dal Trisetetum Flavescens, l'Avena Bionda, tipica foraggera di montagna, denominata "goldhafer" nelle montagne transalpine. Quivi allo scioglimento delle nevi fa subito capolino la graziosa Soldanella Alpina, assieme ai Crochi, mentre il culmine della fioritura si ha all'inizio di giugno, al tempo della prima fienagione con un'indescrivibile varietà di colori. Spiccano, come nell'Arrenatereto, le gialle Crepidi, le bianche Margherite, le Vedovelle, le Campanule, le Potentille, l'Arnica nei suoli con buon accumulo di humus, la Caltha Palustris, i Carici, la Molinia Coerulea ed il Botton d'Oro nelle stazioni fresche ed umide.Dopo la prima fienagione subentra lo sviluppo dei Trifogli, bianchi e rosa, i Geranei violacei, i gialli Leontodi, mentre nell'autunno abbondanti sono i Colchici. Un aspetto del tutto particolare assumono questi prati quando, in condizioni di sufficiente umidità, alla fine di maggio od ai primi di giugno, si ricoprono delle bianche fioriture dei Narcisi, così dense da profumare vasti tratti delle pendici alpine. Da questi prati si passa, a volte con insensibili transazioni, alle altre forme di prateria, ai prati-pascoli ed ai pascoli. Sono in genere praterie magre riconducibili ai Brometi, associazione dai componenti variabili e diversi tra loro, ma sempre caratterizzate dalla presenza del Bromo dei prati, il Bromus Erectus, graminacea dei terreni calcarei aridi e soleggiati.Nelle forme meno xerofile essi si popolano di alcune orchidacee, l'Orchis Morio e Ophrys Apifera, di Antillidi e Ranuncoli.
Accanto ai Brometi formano i pascoli della zona più alta i Nardeti, il Sesliereto-Sempervireto tipico dei pascoli su calcare ed ancora più in alto il Firmeto. I Nardeti sono pascoli magri, poveri di specie, infestati dal Nardo. Questa è una graminacea che ricopre, in tappeti a volte estesi, le pendici non troppo scoscese, di un monotono color verde grigio, cinereo nell'inverno, dai cespi compatti alla base, rifiutato dal bestiame per la sua durezza. Sono caratteristici di questa associazione le Luzule, alcune Potentille, l'Arnica Montana, qualche Genziana, ritrovabili un po' su tutte le malghe abbandonate della zona, Grantagar, Granuda, Cocco, Acomizza.Maggiormente rappresentati e tipici delle zone calcaree e dolomitiche sono i pascoli a Sesleria (Sesleria Coerulea e Sesleria Calcarea) ed a carice sempreverde. Le due specie, pur avendo esigenze diverse, si aggregano e con altre costituiscono un tipo di pascolo largamente diffuso nella zona. La Sesleria, specie pioniera, si accompagna frequentemente sulle zolle friabili delle rocce calcaree agli astri alpini, alla ricercata Stella Alpina,all'Anemone Alpina dai grandi fiori bianchi. Il variopinto tappeto erboso è formato da specie tipiche della montagna, le Genziane, le Primule, le Potentille, le Antillidi, i Trifogli, i Geranei, alcune Viole.Caratteristiche pioniere assume il Firmeto che si afferma sui suoli calcarei, esposti al freddo ed al vento. La cotica non è più compatta, ma si presenta a maglie trattenenti i detriti, soprattutto con i Salici Nani, la Driade, la Genzianella dei calcari, le sassifragae. Una fisionomia del tutto particolare riveste la vegetazione delle rocce e delle rupi, sparse un po' ovunque nel tarvisiano e che hanno nella Potentilla Caulescens il rappresentante più diffuso, nelle sassifragae, alcune Campanule e soprattutto nel Raponzolo di roccia gli elementi di maggior valore estetico. Sulle più alte vette si instaura l'associazione delle cenosi di alta quota, l'Elineto, dal classico tappeto bruno rossastro, dove le condizioni ambientali sono estremamente rigide ed accentuati gli sbalzi di temperatura.